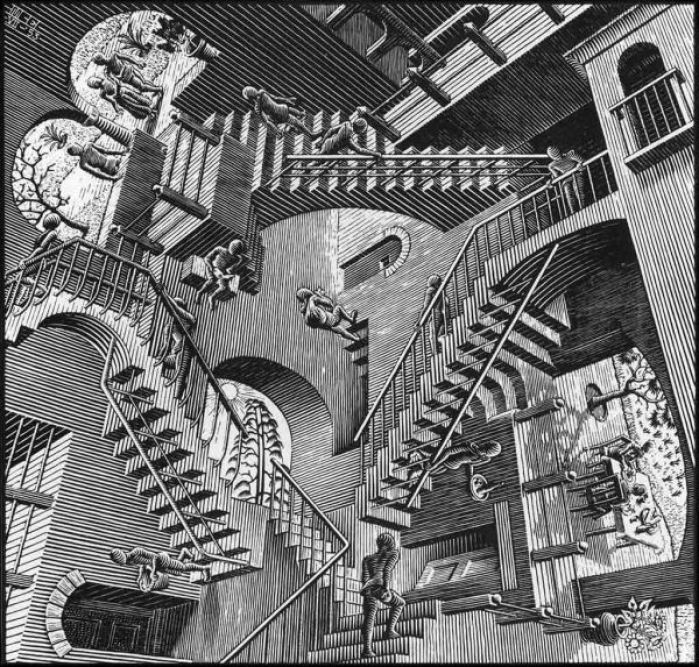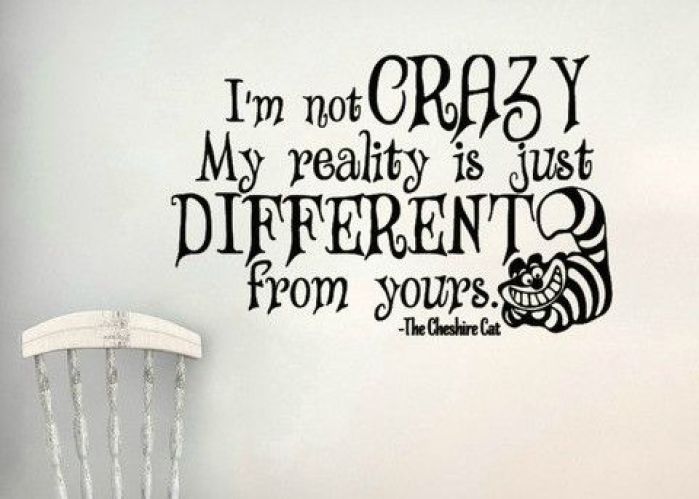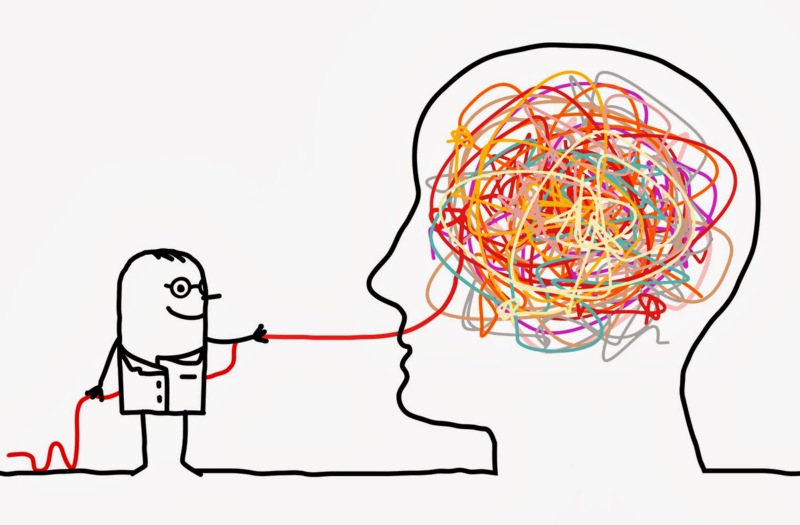
La schizofrenia: un mondo parallelo
Un breve viaggio nel delirio.
Come molti altri termini psichiatrici, anche l’aggettivo “schizofrenico” si sente nominare svariate volte, al telegiornale, tra amici, in coppia… Spesso lo si usa, in maniera inappropriata, per definire qualcuno che cambia idea, o umore, repentinamente.
Ma che origine ha questo termine, ormai cosi inflazionato?
Il “padre” della schizofrenia è considerato E. Bleuler, che raggruppa sotto questo termine una vasta gamma di psicosi il cui elemento comune è una disgregazione della personalità psichica. Prima di Bleuler, Kraepelin chiamava questo quadro “demenza precoce”, intendendo un fenomeno con insorgenza in età giovanile, caratterizzato dall’esito nella demenza.
Bleuler invece evidenzia come tratto caratteristico della schizofrenia il disturbo della strutturazione del pensiero, della sfera affettiva e dei rapporti tra Io e mondo esterno.
Nella schizofrenia si assiste ad un pensiero apparentemente illogico, con associazioni che sfuggono la consueta logica, cariche di simboli che acquistano un significato nuovo e spesso minaccioso. Una macchina che passa per la strada non è più una semplice macchina, ma un messaggio di morte imminente, una persona vestita di nero non è una persona che ama il colore nero, ma un potenziale assassino che vuole uccidere la persona schizofrenica. Tutto acquista un significato rivolto alla persona e non c’è più un confine tra “dentro” e “fuori”: è come se lo schizofrenico fosse senza pelle, se il mondo gli entrasse dentro e lui non riuscisse a tenerlo fuori. Allo stesso modo lo schizofrenico soffre per la cosiddetta “fuga di pensieri”, cioè sente e crede fermamente che gli altri possano rubargli i pensieri ed immettere in lui i loro pensieri. Questo per la già citata mancanza di confine tra sé e il mondo.
("La tragedia del paziente è che si fida di tutto perché non c’è una sufficiente differenziazione tra lui e il mondo: lui invade il mondo e il mondo invade lui"
Prof Giorgio Ferlini, intervista 2012)
Ci sono vari sintomi che permettono di diagnosticare la schizofrenia e varie forme della malattia, da quella cosiddetta “simplex” alla “paranoide’, passando per la forma “ebefrenica” e quella “catatonica”.
Aspetto principale della forma semplice è l’impoverimento della sfera affettiva, intellettiva e della volontà. Nella schizofrenia paranoide invece caratteristici sono i deliri e le allucinazioni, a sfondo persecutorio. La forma ebefrenica è caratterizzata da una grande aridità affettiva, da un comportamento regressivo e primitivo, con forti disturbi del linguaggio. Nella catatonia infine sono seriamente compromesse le funzioni psicomotorie.
Le varie forme possono succedersi nel decorso della malattia, alternando periodi di catatonia ad altri di paranoia, oppure una persona può mantenersi stabile in una delle possibilità sopra elencate. Allo stesso modo possono esserci periodi in cui la malattia si fa più presente ed altri in cui sembra in fase di remissione.
Ci sono varie ipotesi sulle cause della schizofrenia, che si sono susseguite nel corso degli anni, da quando è stato coniato il termine. Si nota sicuramente una familiarità della malattia: è stato infatti individuato un gene a carattere dominante che espone maggiormente al rischio di ammalarsi ma ci sono poi fattori ambientali che ne influenzano il decorso.
Sono stati fatti molteplici esami cerebrali ed è stato evidenziato che i pazienti che soffrono di schizofrenia hanno delle anomalie di carattere strutturale. Tali anomalie, tuttavia, spesso sono presenti anche in soggetti sani e questo avvalora l’ipotesi che in una situazione potenzialmente morbosa ciò che fa la differenza tra la malattia e la salute è il contesto psicoaffettivo.
Nel contesto socio culturale attuale la terapia maggiormente usata è quella farmacologica, a base di neurolettici maggiori che sospendono allucinazioni e deliri.
In questa sede però vorrei proporre una riflessione, un modo personale di intendere il delirio, trasmesso dal mio grande maestro, il Professore Giorgio Maria Ferlini.
In quest’ottica, che unisce psicoanalisi e fenomenologia, il delirio non è un errore, una valutazione sbagliata del mondo. È un altro modo di vedere il mondo, diverso da quello della maggior parte delle persone ma non per questo meno legittimo. Il sintomo, il delirio in questo caso, è un messaggio, una comunicazione che non può essere fatta altrimenti. Se lo guardiamo come un errore, come un sintomo negativo che va eliminato perdiamo ogni possibilità di incontro con l’altro.
("La positivizzazione significa vedere nel sintomo un simbolo, non il segno della malattia, ma il segno che il paziente fa per comunicare a noi qualcosa; si tratta di un simbolo carico di significato."
Prof. Giorgio Maria Ferlini, Padova, Convegno Tre scuole di psicoterapia a confronto, 9 ottobre 2010)
A mio avviso il delirio è l’unico modo che la persona ha trovato per stare al mondo. Ha costruito un mondo ‘altro’ in cui tutto ha un significato, solo che è un significato difficilmente comprensibile se si utilizza la logica che conosciamo. Ma per fare un intervento terapeutico, nell’accezione di cura (prendersi cura) è necessario comprendere tali significati, per quanto strani e distanti da noi possano essere. Il Professor Ferlini diceva sempre che bisogna scendere nelle fauci del drago insieme al paziente, con una mano tesa di qualcuno che ci aiuti ad uscirne.
Il fatto che non comprendiamo immediatamente i significati del paziente non significa che questi non abbiano senso. È un altro modo di stare al mondo ma È UN MODO DI STARE AL MONDO, uno dei modi possibili. E dunque io trovo assolutamente scorretto eliminare il delirio, perché si priva la persona della possibilità di essere, nel modo in cui è riuscita. Si possono inserire degli elementi vitali ma entrando nel mondo del paziente, non cercando di portare lui nel nostro mondo, pensando che sia il nostro ad essere giusto. Il mondo che si è costruito, il delirio che porta avanti è un tentativo estremo di esistere e noi non abbiamo nessun diritto di privarlo di questa esistenza. Spesso infatti si assistono ad episodi di suicidio proprio nel momento in cui la persona pare stare meglio, a detta di chi la circonda, perché non ha più i deliri. Ma è proprio nel momento in cui il delirio si sgonfia che la persona si trova gettata in un mondo in cui non riusciva a stare, tanto da doversene costruire un altro. E quando non trova più la possibilità di rifugiarsi nel proprio mondo privato di significati, la sofferenza è tale da spingerlo a togliersi la vita.
Il delirio può andarsene se il paziente trova un altro modo per costruire la sua identità perché finchè c’è il delirio c’è anche identità: il delirio è un estremo tentativo di autoaffermazione. La terapia consiste proprio in questo, nell’aiutare il paziente, attraverso delle “esperienze emotive correttive” ad affermarsi senza il delirio, a costruirsi una identità che non necessiti di un mondo delirante di significati privati. Ma per farlo ci vuole tempo, empatia, costruzione di un mondo/delirio condiviso, in cui il terapeuta si cala, mantenendo sempre un aggancio con la realtà ed inserisce elementi vitali e costruttivi.
("Meno si cerca di contrastare il delirio, più è facile
che il delirio se ne vada. Il delirio fa parte di un pezzo di vita e non se ne andrà mai del tutto. Il delirio va appoggiato, avrà meno bisogno di un simbolo, perché il delirio è l'estremo tentativo
di autoaffermazione. Il delirio non va contrastato, ma va accettato, perché dà un'identità al paziente. Quando il paziente passerà per un'esperienza diversa, potrà avere una propria identità senza
delirio".
Lezione di psicoterapia psicoanalitico fenomenologica, 2010, Giorgio
Ferlini)
Come dice lo Stregatto di “Alice nel Paese delle meraviglie”… non è detto che perché non comprendiamo il mondo dell’altro questo sia sbagliato.